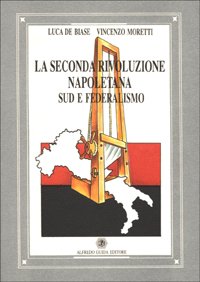L’eroe dei due mondi
Quando Giuseppe Garibaldi arrivò a Napoli, dopo avere conquistato il Regno delle Due Sicilie, chiese a Carlo Cattaneo di raggiungerlo. Dopo tanta “azione” sentiva il bisogno di fermarsi a “pensare”, di essere consigliato sul che fare. Il federalista milanese accettò l’invito con entusiasmo, in quanto immaginava, o perlomeno questa doveva essere la sua speranza, che il condottiero nizzardo potesse indirizzare la sua linea e le sue scelte verso la creazione degli Stati Uniti d’Italia. Troppe differenze, a suo parere, esistevano tra il Nord e il Sud, tra i territori dello Stato Pontificio e quelli della Corona piemontese. Più che al modello francese, pensava Cattaneo, l’unificazione italiana doveva guardare all’esperienza nordamericana. Ma a Napoli, Carlo Cattaneo rimase solo un mese. Gli apparve infatti subito chiaro che sulle scelte di Garibaldi esercitava una decisiva influenza il filone di pensiero politico che aveva la massima espressione in Camillo Benso, il primo ministro piemontese. Ed il conte di Cavour era uno che, per cultura e per interessi, pensava invece proprio al modello francese. Non a caso realizzò l’unità d’Italia con operazioni che oggi si possono chiamare, senza mezzi termini, coloniali.
Lo dimostra il fatto che già negli anni immediatamente successivi al 1860 le popolazioni meridionali sentirono tutto il peso della distanza politica e culturale che le separava dal re del Piemonte. Avvertirono, o per meglio dire sperimentarono sulla propria pelle, la rottura traumatica della struttura sociale alla quale erano abituati. Molti presero le armi, in quella che Renzo Del Carria ( Proletari senza rivoluzione, Savelli, 1976) definirà “una guerra guerreggiata, che si protrasse nel suo nucleo centrale per almeno quattro anni, interessando mezza Italia, che si concluse con 7.000 morti in combattimento, oltre 2.000 fucilati (contando solo quelli delle statistiche ufficiali) e 20.000 prigionieri, condannati ai lavori forzati o confinati (…)”. Una vera e propria guerra di occupazione, dunque, attraverso la quale lo Stato centralistico si impose con la violenza alle popolazioni meridionali. Cattaneo, deluso, avrebbe in seguito definito Giuseppe Garibaldi “un filibustiere”. Ma in realtà, lo stesso “eroe dei due mondi” fu tradito nelle sue aspettative da coloro che ressero le sorti di quel nuovo Stato alla cui creazione egli pure aveva contribuito in maniera determinante.
Alle radici dell’unità d’Italia c’é stata dunque una scelta storica decisiva. L’istituzione dello Stato centralistico é stata infatti determinata dall’ importazione del modello francese, che dominava la mentalità dei piemontesi, i veri conquistatori del resto d’Italia. Non solo il progetto di Cattaneo non fu mai veramente preso in considerazione, ma lo strappo che si determinò nella cultura e nella storia del Sud in seguito all’imposizione del modello sabaudo segnerà profondamente i rapporti tra il Sud ed il resto del Paese. Dopo di allora, lo Stato centrale ha cercato legittimazione al Sud, spesso, sempre più spesso, attraverso decisioni che hanno reso il Mezzogiorno dipendente dalle scelte e dagli aiuti provenienti da Roma. Una tendenza, questa, che ha conosciuto la sua età dell’oro nel corso del secondo dopoguerra e che ha consentito al ceto che ha gestito la relazione tra Roma e Napoli, di realizzare un profitto politico (e spesso economico) di enormi dimensioni. L’opzione federalista, per il Sud, é stata totalmente dimenticata.
Ma oggi la situazione é mutata radicalmente. Una rivoluzione, anche se certamente ancora parziale, é passata sul sistema di potere che per decenni ha dominato Napoli. Le teste dei politici, degli imprenditori e, addirittura, di alcuni boss della camorra sono cadute. La magistratura ha portato la stoccata decisiva al cuore di un ceto di potere che vedeva già per altri versi minacciata e messa in discussione quella legittimità che per lunghi anni la popolazione gli aveva riconosciuto. Alla base delle incalzanti novità recentemente verificatesi a Napoli c’é infatti, come abbiamo visto, una crisi di rappresentanza, di legalità e di efficienza. La maggior parte della popolazione aveva legittimato il potere del vecchio ceto dominante, aveva chiuso un occhio sulle sue frequenti concessioni all’illegalità, note a tutti, anche e soprattutto perché il sistema, seppure in maniera distorta, in qualche modo funzionava. Dava lavoro, alimentava i consumi, ispirava speranze nei furbi senza scoraggiare completamente i leali. Ma una serie di fenomeni ha rotto l’equilibrio. In particolare va ancora una volta sottolineato come la fine dell’afflusso di capitali da Roma, negli anni Ottanta diventato un vero e proprio torrente in piena, ha messo in discussione il funzionamento del sistema, almeno per quanto riguardava la sua capacità di rispondere alle esigenze di tutti coloro che erano sussidio-dipendenti dallo Stato centrale. Questo fenomeno ha finito con il disinnescare il meccanismo di potere precedentemente stabilizzato ed allora l’illegalità sulla quale si basava il vecchio regime é divenuta via via sempre più inaccettabile. Di conseguenza, anche i politici hanno cominciato a non essere più considerati come i veri e legittimi rappresentanti del popolo. Le teste che poi la magistratura avrebbe metaforicamente mozzato, erano per così dire già predisposte alla caduta nel momento in cui avevano perso la loro legittimità. Il senso della fine di un’epoca, il bisogno di rifondare tutto é diventato tanto palese da spingere il procuratore capo di Napoli Agostino Cordova, venerdì 4 marzo 1994, a definire la città in cui lavora “la capitale della corruzione, un male che parte da qui e si irradia in tutto il resto della Nazione”. Parole esasperate, terribili. Forse esagerate. Sistemi che hanno bisogno per loro natura di forte capacità di interazione rendono estremamente difficile l’isolamento anche geografico di un “centro”. Probabilmente é più giusto immaginare che vicende come Tangentopoli abbiano più centri propulsivi ed organizzativi. Ma non per questo le parole di Cordova sono meno significative del clima da fine di un’epoca che si respira nel capoluogo campano.
Federalismo, non secessione
Torniamo dunque inesorabilmente al filo conduttore del ragionamento proposto in questo libro. Abbiamo detto che perché la rivoluzione, per ora parziale, si compia, non basta il ricambio delle persone che gestiscono il potere. Occorre un mutamento delle regole istituzionali che governano la convivenza. Ebbene, questo mutamento sta diventando possibile. Anche perché, nel frattempo, e per motivi in fondo analoghi, anche al Nord tutto é cambiato. La richiesta di cambiamenti istituzionali é diventata generale. Anzi, proprio il Nord ha considerato per primo un ritorno al pensiero federalista e lo ha fatto sulla base di una considerazione di convenienenza economica e di distanza culturale dal resto d’Italia.
Ma a questo punto si impone una riflessione su questo argomento anche da un punto di vista meridionale. Una riflessione che non sia determinata, né condizionata, da questioni ideologico-culturali. Visto da Sud, il problema non può essere quello di difendere l’idea dello Stato centrale come si é venuto strutturando dopo la conquista piemontese. La vera questione che é davanti ai meridionali é quella di valutare ed analizzare, anche per il Mezzogiorno, la convenienza economica e culturale di un passaggio istituzionale orientato all’introduzione di un sistema davvero federalistico.
Perché, é bene chiarire subito questo punto prima di andare avanti, il federalismo é cosa completamente diversa dalla secessione. Se é vero che la Lega Nord di Umberto Bossi ha giocato su questa ambiguità per lunghissimo tempo, questo non significa però che federalismo e seccesione siano effettivamente concetti vicini. Sono invece opposti. Non per nulla Cattaneo pensava agli Stati Uniti d’Italia, dove la parola “uniti” aveva un peso certamente pari al fatto che gli “stati” fossero espressi al plurale.Del resto, Bossi ha giocato saggiamente, dal suo punto di vista, sull’ambiguità. La minaccia della secessione era coerente con la sua analisi politica. Che non é certamente priva di riscontri. Nel corso di una puntata di Milano Italia, la trasmissione di RaiTre, egli ha affermato per esempio che “La società italiana aveva la febbre alta. Poi é arrivata l’operazione Mani Pulite. Ed é stato come se le avessero schiacciato un foruncolo. Da allora la febbre é calata”. Detto in altri termini, il dominio del partitismo basato sull’alleanza, per certi aspetti illegale, tra il democristiano Giulio Andreotti e il socialista Bettino Craéi, era divenuto progressivamente intollerabile. Il sistema non reggeva più, né dal punto di vista economico né da quello politico. L’Italia era pronta alla “rivoluzione”, parola che Bossi usa molto più spesso degli esponenti dei partiti post-comunisti. E la secessione era la rivoluzione che la Lega Nord poteva e voleva minacciare. Il passaggio al federalismo, invece, non traumatico e non violento, poteva diventare un’opzione reale proprio nel momento in cui l’Italia fosse sfebbrata e dalle “minacce” di rivoluzione si potesse passare al concreto cambiamento fondato su un serio programma di riforme.
Ma perché il sistema di Andreotti e Craéi era considerato come una malattia tanto grave da far salire il termometro della società italiana oltre il tollerabile? A questa domanda, la risposta di Bossi non é stata sempre altrettanto lucida. Del resto, il fenomeno che spiega la febbre é sfuggito anche alla maggior parte degli altri partiti.
È un fenomeno radicato in un fatto accaduto negli anni Ottanta e che ha mutato profondamente il tessuto sociale e politico degli italiani. Proprio alla metà di quel decennio, vedeva la luce una edizione riveduta e corretta del classico Saggio sulle classi sociali dell’economista Paolo Sylos Labini, con il nuovo titolo Le classi sociali negli anni ’80. L’immagine dell’Italia che ne emergeva era stupefacente: il Paese uscito dalla guerra con un 40 per cento della popolazione ancora occupato in agricoltura e poi trasformato dalla accelerata urbanizzazione resa necessaria dalla rivoluzione industriale non era più fatto prevalentemente da lavoratori dipendenti. Messe insieme, borghesia e classi medie urbane erano arrivate a contare, nel 1983, per il 49 per cento del totale della popolazione. Quello stesso ceto medio, nel 1971, non superava il 40 per cento. La borghesia vera e propria (imprenditori, dirigenti, grandi professionisti) era passata dal 2,6 al 3,3 per cento. Le classi medie urbane erano a loro volta cresciute in modo spettacolare: dal 37,9 per cento del 1971 al 45,7 del 1983. Di lì a poco questo nuovo ceto medio sarebbe diventato la maggioranza degli italiani.
La Malfa e la crisi dei partiti
I vecchi partiti non sembravano accorgersene. O, in ogni caso, non sembravano in grado di reagire. Proprio nel 1986, intervistato dall’Espresso, Giorgio La Malfa, segretario del Partito Repubblicano Italiano, affermava: “Secondo me a subire un vero e proprio trauma sono i partiti che formano l’asse tradizionale del sistema politico italiano, ovvero la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. Il nuovo saggio di Paolo Sylos Labini dimostra senza ombra di dubbio che i ceti medi sono ormai maggioritari rispetto ai lavoratori agricoli e agli operai. Eppure il sistema politico italiano é ancora impostato secondo lo schema degli anni Cinquanta. Ora che il panorama é tutt’altro, siamo fermi là. La società civile se ne accorge, tant’é vero che i voti per i repubblicani sono aumentati. E nasce il localismo, la Lega”. Chiede l’Espresso: “E i socialisti, che da sempre ambiscono a rappresentare l’Italia moderna?”. Risponde il segretario repubblicano: “I socialisti rappresentano l’immagine della politica senza scrupoli, dell’inefficienza, dello statalismo, anche della corruzione. Non conquisteranno l’Italia moderna”. Correva l’anno 1986: quanta preveggenza nelle parole di La Malfa. I vecchi partiti in crisi, la Lega in ascesa, i socialisti senza legittimità, la spinta del ceto medio. Eppure, il sistema politico rimase bloccato. Sarà stato per il fatto che il Muro di Berlino era ancora in piedi. Sarà stato perché le finanze italiane apparivano floride e la Borsa andava a mille. Sta di fatto che per altri sei anni nulla (o quasi) cambiò, nel panorama partitico, e che il Paese si buscò una delle febbri più gravi della sua storia.
Il cosiddetto Caf (l’accordo di potere fondato sull’alleanza tra Craéi, Andreotti e Forlani) é stato dunque un sistema accettato fino a che ha funzionato. O meglio, fino a che il contesto economico e politico non ha incontrato una crisi che il Caf stesso non ha saputo affrontare. Che la si chiami recessione internazionale, legata alla Guerra del Golfo, che la si pensi come frutto della caduta del Muro di Berlino e della conseguente cessazione della Guerra Fredda, resta il fatto che con la trasformazione dell’assetto economico e politico che aveva consentito al Caf di “tirare a campare”, come diceva Giulio Andreotti, si sono determinate le condizioni perché il peso del vecchio sistema diventasse intollerabile. La recessione ha eliminato la possibilit_ di finanziare illimitatamente il sistema attraverso il debito pubblico, come dimostra Alessandro Wagner nel libro Due milioni di miliardi: l’incredibile ma vera storia del debito dello Stato (Mondadori, 1993). La fine della Guerra Fredda ha tolto di mezzo le forme di sostegno internazionali che garantivano la continuità della classe dirigente italiana perché considerata garante della necessità di tenere il Paese fuori dall’orbita sovietica, come afferma Gianni Cipriani nel coraggioso volume I mandanti già citato. La stessa opposizione di sinistra italiana si é probabilmente trovata per una certa fase disorientata da queste novità anche se é poi riuscita a limitare i danni consumando il suo strappo, lungamente annunciato, dalla tradizione comunista e approdando definitivamente sulle sponde del socialismo europeo.
La crisi di legittimità del sistema consociativo che si era costruito intorno al Caf é stata dunque prima di tutto una crisi di efficienza: nel nuovo contesto quel sistema non funzionava più. E la società italiana, nella quale il ceto medio aveva assunto una posizione via via più rilevante, ha reagito cercando nuove legittimità e nuovi rappresentanti. Lo dimostra il consenso che si é creato intorno all’opera della magistratura nel corso delle operazioni Mani Pulite condotte nelle diverse città italiane, del quale non c’era stata traccia quando in precedenza operazioni analoghe erano state tentate da magistrati altrettanto coraggiosi.
E lo dimostra la storia stessa della Lega Nord. Prima di appoggiarsi sul ceto medio, Bossi cercò legittimità nella cultura settentrionale, cercando di contrapporla a quella meridionale. Era la strada già percorsa, con esiti fallimentari, della Liga Veneta. Da quella parte anche la Lega Nord non sarebbe andata lontano. In fondo, il senso di tolleranza per le culture diverse faceva parte della modernità della gente del Nord, era stato interiorizzato nel corso di decenni di vita di un Paese nel quale vigeva un sistema che per quanto imperfetto era pur sempre democratico. E non bisogna dimenticare che l’immigrazione dal Sud, oltre a determinare concreti processi di integrazione, aveva contribuito in maniera significativa allo straordinario boom economico vissuto proprio dal Nord. L’intolleranza, certo presente, non era assolutamente maggioritaria. Ma ben presto Bossi trovò la sua strada per la conquista della maggioranza relativa al Nord, cambiando rotta e cercando nuovo slancio nella protesta fiscale. E allora sì che il suo “messaggio” fece breccia. Perché se il razzismo non era maggioritario in Lombardia, il ceto medio della regione avvertiva sempre di più il peso dello scambio ineguale che era costretto a subire: tasse sempre più elevate in cambio di servizi pubblici sempre meno paragonabili a quelli che vedeva garantiti dagli Stati del Nord Europa.
Il Centro Sud non crede a Bossi
Fu proprio la scelta decisamente settentrionalistica della Lega Nord che determinò, allo stesso tempo, il suo rapido radicamento in alcune regioni, ovviamente del Nord, e la sua sostanziale incapacità di superare i vincoli localistici. Anche quando cominciò a parlare di federalismo, non convinse gli elettori centro-meridionali. La sua impostazione risentiva troppo delle origini. Tutte le sue parole venivano lette con il pregiudizio, probabilmente fondato, che essa fosse una forza politica interessata a rappresentare esclusivamente gli interessi del Nord.
In realtà, il concetto di federalismo non appartiene esclusivamente al Nord. E del resto non si può immaginare alcuna sua concreta applicazione senza il consenso di tutti, compresi gli abitanti dei territori meridionali. Non solo. E’ del tutto ragionevole immaginare un federalismo visto da Sud. Del resto, molti leader nazionali non nascondono di pensarci. Achille Occhetto, segretario del Partito Democratico della Sinistra, nel corso di una puntata di Il rosso e il nero, di RaiTre, si mostrò molto interessato al concetto di federalismo. Al punto da lanciare a Bossi il seguente invito: “Se vogliamo ragionare seriamente di federalismo, incontriamoci a parlarne”. Non lo fecero. Ma all’ipotetico tavolo di quella discussione sarebbero forse potute emergere alcune idee di valore nazionale. Lo dimostra, per esempio, uno studio dell’Istituto per la ricerca sociale (Irs), di Milano, una società di economisti certamente orientata in senso progressista.
Che cosa hanno trovato i ricercatori dell’Irs? In generale hanno scoperto che l’insoddisfazione per il sistema fiscale centralistico ha ragione di essere non soltanto al Nord. Anche se, é vero, sono proprio al Nord le regioni che, dal punto di vista contabile, ci rimettono. Secondo l’Irs, ogni cittadino della Lombardia, neonati compresi, fatta la differenza tra i 12 milioni e 700 mila lire versati per le imposte e i 7 milioni e 770 mila lire ricevuti dallo Stato sotto forma di servizi pubblici, ci perde quasi 5 milioni. Le regioni che pagano più di quanto ricevano, oltre alla patria di Bossi, sono l’Emilia Romagna (2.475.650 lire di differenza media), il Piemonte (2.264.390), il Veneto (2.107.260), la Toscana (1.281.190), le Marche (488.180) e il Friuli Venezia Giulia (32.860). Tutte le altre regioni ricevono più di quanto diano allo Stato centrale. Il record spetta alla Basilicata i cui cittadini nel rapporto con Roma guadagnano in media 4 milioni e 105 mila lire, ma tutte le regioni meridionali sono più o meno in queste condizioni. Le loro medie sono infatti comprese tra quella della Lucania e quella dell’Abruzzo, i cui abitanti ottengono dallo Stato centrale quasi un milione e mezzo in più di quanto paghino. In totale, sono 50 mila i miliardi che escono da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche, per andare alle regioni centro-meridionali. Fin qui le ragioni dei nordisti arrabbiati.
Ma l’Irs, per apparente paradosso, conforta anche i meridionalisti: innanzitutto avvertendo che altri 20 mila miliardi partono dalle stesse regioni del Nord per andare nel Lazio e in zone ben poco mediterranee come la Val d’Aosta e il Trentino Alto Adige. La Val d’Aosta, in particolare, é sorprendentemente al secondo posto, la regione più favorita dopo la Basilicata, con un avanzo medio per abitante superiore ai 3 milioni e mezzo di lire.
“Inoltre c’é da considerare la qualità della spesa” precisa Pia Saraceno, economista dell’Irs. “Lo Stato spende di più al Nord che al Sud per la sanità, le pensioni, i servizi comunali. Mentre il Mezzogiorno incassa in misura maggiore solo per quanto riguarda il mantenimento dei dipendenti pubblici”. Morale della favola: “dove é finora prevalso il sistema del voto di scambio, la qualità dei servizi é andata in secondo piano rispetto alla gestione delle fedeltà politiche e dell’assegnazione dei posti di lavoro garantiti”. I dati sono confermati dal ministero del Tesoro: la spesa pro capite per il personale statale supera il milione e mezzo al Sud e si ferma a un milione e 100 mila nel Nord-ovest e nel Veneto. Nello stesso tempo, la spesa sanitaria pro capite ammonta a un milione e 600 mila lire al Nord e a un milione e 400 mila al Sud, con punte vicine ai due milioni in Emilia Romagna e vicine al milione in Calabria. Insomma, a Bologna e Milano lo Stato offre più servizi, a Napoli e Reggio Calabria garantisce soprattutto stipendi. “Se questa politica non ha ridotto le distanze tra Nord e Sud finora” conclude Pia Saraceno “vuol dire che é una politica sbagliata”.
Alla Campania il primato della spesa pubblica
È vero. Lo Svimez, l’Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno, conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che le condizioni di relativa arretratezza del Sud rispetto al Nord non si sono ancora attenuate dopo decenni di interventi che avrebbero invece dovuto garantire il sostegno allo sviluppo da parte dello Stato centrale. Il centro di ricerche osserva che solo sei regioni producono più di quanto consumino e precisamente il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana ed il Lazio. Il primato della spesa pubblica va alla Campania con l’8,4 per cento di assorbimento delle risorse dello Stato, contro un contributo al Prodotto interno lordo del 6,7 per cento. La Lombardia invece, con il 15,5 per cento della popolazione nazionale, produce il 20,4 per cento del Pil e assorbe il 16,3 per cento dei fondi pubblici. E i redditi medi delle famiglie danno in sintesi l’idea della distanza che ancora separa il Paese: una famiglia del Centro-Nord guadagna 3 milioni 382 mila lire, contro i 2 milioni e 612 mila della famiglia media meridionale. Senza contare che il peso economico complessivo del Nord resta clamorosamente superiore: i tre quarti delle esportazioni italiane sono prodotte nel Settentrione, contro un 10 per cento scarso che proviene dal Sud. Segno evidente del fatto che i prodotti competitivi, quelli che, o per prezzo o per qualità riescono a battere la concorrenza internazionale, sono fabbricati prevalentemente al Nord. Il Sud vive di attività che si confrontano ben poco con l’estero, e che dunque o non sono fatte abbastanza bene o non hanno un prezzo abbastanza conveniente. L’industria meridionale, quella che é stata generata da decenni di politiche orientate al suo sostegno ma pensate a Roma, fatte le debite eccezioni, non si dimostra in grado di vivere senza aiuti esterni, non si sa autoalimentare. Non genera quindi sviluppo.
Insomma, il centralismo non si é rivelato poi tanto efficace per risollevare le sorti del Meridione d’Italia. Perché mai il Sud dovrebbe difenderlo?
Non c’é nessuna ragione particolarmente valida, a meno che il Meridione non voglia prestarsi al gioco chi lo accusa di volersi far mantenere dal Nord. Introdurre elementi di forte cambiamento, nella situazione attuale, può dimostrarsi convieniente per tutti. Allo stato, se il Nord ci rimette sul fronte delle tasse il Sud non ci guadagna su quello dei servizi. Una delle ragioni principiali sta nel fatto che una parte significativa dei soldi si perde in mille rivoli, senza un controllo sulla qualità della spesa. Un esempio? In tre anni, dal 1989 al 1992, gli straordinari del personale sanitario siciliano sono aumentati del 419 per cento e le indennità notturne addirittura del 2.991 per cento. Ma non é per questo detto che l’assistenza ai malati sia migliorata in proporzione. Ancora: a Napoli, il primo grande comune d’Italia dichiarato tecnicamente fallito, il patrimonio immobiliare municipale é fuori controllo e più di un terzo degli inquilini che abitano in case costruite con i soldi del terremoto non hanno mai pagato una lira d’affitto. Del resto, se c’é qualcosa di cui il Sud non ha avvertito la mancanza sono stati gli scandali finiti sulle prime pagine dei giornali, con in pole position i famigerati 50 mila miliardi stanziati a favore delle aree terremotate del Meridione. Una somma sufficiente a comprare 250 mila appartamenti, capaci di ospitare un milione di cittadini, come dire tutta Napoli. Migliaia di miliardi che invece, secondo la ricerca pubblicata dall’Eurispes più volte citata, si sono spesso riversati su imprese fantasma, che non hanno creato vera occupazione e certamente non hanno innescato un meccanismo di sviluppo capace di sostenersi sulle sue gambe. Senza dimenticare che spesso quelle imprese fantasma erano propaggini di aziende che venivano dal Nord e che al Nord riportavano i profitti.
E allora? Che cosa possono sperare di ottenere da Roma le popolazioni meridionali? Non ci pare si possa rispondere che il Sud non vuole il federalismo per lealtà allo Stato centralistico. L’ideologica adesione alle istituzioni dell’Italia unita non sta certo di casa al Sud. Lo segnalano le ricerche molto approfondite e particolarmente originali che sono state realizzate dal politologo americano Robert Putnam, autore del libro La tradizione civica nelle regioni italiane. Scrive Putnam che “Il grado di apprezzamento degli elettori nei riguardi delle rispettive amministrazioni nazionali, regionali e comunali dimostra chiaramente che, secondo la maggior parte degli italiani, nella gerarchia amministrativa italiana l’efficacia é tanto maggiore quanto più ci si allontana dal governo nazionale e ci si avvicina al governo locale. Nel Nord per gli elettori vi é una forte differenza tra il governo centrale da un lato, nei confronti del quale la maggioranza ha profondi motivi di insoddisfazione e il governo regionale e comunale dall’altro, del quale sono invece relativamente soddisfatti. Per contro, chi abita al Sud accomuna nelle critiche all’amministrazione centrale anche i comuni e le regioni. I sentimenti rispecchiati in questi dati furono precisamente il retroscena cruciale per lo sviluppo della Lega Nord negli anni Novanta”. Altro che lealtà all’Italia unita: l’idea federalista é stata favorita al Nord dalla legittimità della dimensione locale del politico, mentre al Sud incontra ostacoli che niente hanno a che vedere con il senso di fedeltà all’unità d’Italia e che sono a loro volta praticamente insormontabili senza profondi cambiamenti istituzionali. Se la gente del Mezzogiorno non si é abituata a credere che le sue condizioni migliorerebbero molto riducendo il potere della politica romana, é semplicemente perché ritiene che anche la politica napoletana, palermitana o reggina non sia particolarmente soddisfacente.
E dunque, se non é la lealtà allo Stato unitario, le perplessità che la popolazione meridionale sembra opporre all’idea federalistica sono di altra natura: sono di convenienza, come é giusto che sia. Per decenni, lo Stato centrale é stato il motore dello sviluppo. Uno sviluppo drogato, disordinato, mai capace di alimentarsi autonomamente, sempre bisognoso di ulteriori afflussi di capitali dall’esterno. Ma pur sempre sviluppo. E dunque, non é facilmente sradicabile l’idea che sia indispensabile difendere lo Stato centrale per mantenere intatte le speranze di continuità con quel modello di sviluppo.
Le cifre di un fallimento
Ma sarebbe un errore fatale. Il Paese, in realtà, é giunto a un punto nel quale continuare a guardare al passato, tentare di difendere il passato, non può che dimostrarsi controproducente. Dal punto di vista organizzativo, si può affermare senza tema di smentita che il vecchio sistema centralistico é fallito. Lo Stato ha accumulato un debito che supera il milione e 800 mila miliardi. Se si aggiungono le pensioni che é già sicuro di dover pagare in futuro, il settore pubblico é debitore per quasi 4 milioni di miliardi. Un peso che impedisce ogni libertà di manovra. Già oggi le entrate fiscali superano le uscite per il mantenimento dei servizi pubblici, ma bastano gli interessi che lo Stato deve pagare per finanziare i suoi debiti a generare un deficit da 140-150 mila miliardi. Una relazione del ministro del Tesoro, Piero Barucci, é a questo proposito molto esplicativa: nel 1990 su 100 lire entrate nelle casse pubbliche se ne sono spese 130, di cui 29 per pagare gli interessi sul debito; nel 1993 se sono uscite 129, ma ben 42,8 per gli interessi.
Una spirale suicida. Continuando così lo Stato in poco tempo dovrebbe destinare tutte le sue risorse al pagamento degli interessi e non avrebbe più una lira da spendere in ospedali, pensioni e scuole. Tanto meno potrebbe aumentare i finanziamenti ai consumi delle popolazioni che abitano nei territori meno sviluppati del Paese. Eppure, il debito pubblico per anni é cresciuto più del prodotto interno lordo. Nel 1990 lo ha superato e nel 1993 lo staccato quasi del 20 per cento. “Storicamente” avverte Giorgio Radaelli, economista della banca d’affari anglosassone Lehman Brothers, “quando il rapporto tra debito e Pil supera il 130 per cento lo Stato fa bancarotta”. E a quel punto, non c’é più niente da sperare, né in termini di finanziamenti allo sviluppo, né in termini di semplice continuità con il passato. Sta di fatto che il rapporto tra debito e Pil arriverà al 123 per cento nel 1994, secondo le proiezioni dell’Irs, e cesserà di aumentare solo nel 1996, a patto che le spese dello Stato non aumentino sconsideratamente, o che le tasse raccolte non diminuiscano improvvisamente. Si possono aumentare le tasse per poter aumentare anche le spese? No. La pressione fiscale é già molto elevata e aumentarla ancora significa diminuire la crescita complessiva dell’economia. Sarebbe una toppa peggiore del buco. È invece il momento della riduzione delle spese. O almeno della fine del loro aumento. Chi può sensatamente pensare, in queste condizioni, di poter costruire uno sviluppo sulla base di finanziamenti pubblici concepiti alla maniera sperimentata in passato? Nessuna forza politica oggi in campo lo sostiene. Non il Partito democratico della sinistra, non il Patto per l’Italia o il Partito popolare italiano, non Forza Italia o la Lega Nord. Anche se qualche differenza, non di poco conto, é testimoniata dai loro programmi.
Spiega Filippo Cavazzuti, economista del Pds e vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato nella passata legislatura: “Siamo vincolati, in primo luogo, al mercato unico europeo. In queste condizioni, qualunque regime fiscale troppo pesante fa scappare i capitali in un altro Paese”. Date queste limitazioni, per il Pds nel breve periodo si deve puntare sulla riduzione ulteriore dei tassi di interesse ed evitare assolutamente qualunque aumento delle imposte patrimoniali. E nel medio termine? “Si può riordinare l’imposizione fiscale sul risparmio in modo da favorire il capitale di rischio. Abbassando le tasse sugli utili delle imprese che sono tartassati: tra Irpeg e Ilor arrivano a pagare oltre il 60 per cento. Niente cambierà invece per i Bot”. Con gradualità, si favoriranno poi i fondi pensione, dando a loro la gestione del trattamento di fine rapporto (Tfr) per dare ai lavoratori una pensione integrativa. Il rilancio dell’economia passerà dalla fiscalizzazione mirata degli oneri sociali che dovrebbe sostenere gli investimenti delle imprese e, come sottolinea Massimo Di Marco, responsabile dei problemi economici del Pds lombardo, dal finanziamento di opere pubbliche, del riordino ecologico, delle iniziative tese a rispondere alle esigenze degli anziani e degli handicappati. Il tutto con una decisa attenzione alle problematiche territoriali e locali. “La pressione fiscale non cambierà. Potremmo ridurre il numero e l’incidenza delle aliquote Irpef marginali e aumentare l’Iva. Ma sempre in accordo con la Comunità europea. E certamente le spese non aumenteranno in maniera da accrescere i problemi del bilancio pubblico” aggiunge Cavazzuti. “In ogni caso occorrerà rivedere le attribuzioni delle competenze tra Stato centrale ed enti locali”. Il Pds prevede infatti alcune forme di decentramento già per l’immediato. Ma va segnalata anche l’esistenza di un profondo dibattito nell’ambito della sinistra sulla questione federalista. Che può generare alcune sorprendenti conseguenze. Sulle quali si ritornerà in seguito.
Anche Augusto Fantozzi, tributarista e autore del programma fiscale del Patto di Mario Segni prevede una sostanziale continuità nella finanza pubblica. “Anzi, si può ridurre anche l’Ici e inserirla in un più chiaro sistema di imposte locali che riguardi anche una parte dei redditi”. La revisione dell’imposizione delle rendite finanziarie può spingersi tutt’al più a un’omogeneizzazione del trattamento dei depositi bancari (che oggi pagano il 30 per cento) e dei Bot (attualmente al 12,5 per cento). “Ma si resterà nel sistema delle cedolari secche, al quale si potrebbero portare anche i dividendi azionari”. Certo, ammette Fantozzi, “non si potranno abbassare le tasse miracolosamente. La pressione fiscale diminuirà gradualmente se ci sarà una ripresa della crescita del Pil”. Anche attraverso un aumento della spesa pubblica? “Sì, facendo economie per evitare gli sprechi e orientandola alle grandi opere pubbliche”. Quanto alla questione del decentramento e del centralismo, il Patto prevede il sostanziale mantenimento della situazione attuale per quanto riguarda le attribuzioni delle regioni e dello Stato centrale, con tutt’al più una leggera forma di decentramento.
Gli altri programmi, per il breve termine, non si discostano troppo da questi. Una priorità, per la destra, é la garanzia di continuità di trattamento per i risparmiatori. “Gli accordi vanno rispettati” spiega Antonio Martino, economista di Forza Italia. “I risparmiatori che hanno avuto fiducia nello Stato non devono essere derubati. Anche perché facendolo i tassi salirebbero a livelli da usura”. Tuttavia occorre invertire la rotta: spesa pubblica e tasse devono cominciare a crescere meno del Pil. “Proponiamo di affiancare all’obbligo di copertura delle leggi di spesa, sancito dall’articolo 81 della Costituzione, un tetto alla fiscalità garantito anch’esso dalla Costituzione”. Questo incoraggerebbe il risparmio e l’investimento privato, riducendo lo spiazzamento delle risorse a favore del pubblico. Aumenterebbe così lo spazio di manovra per le imprese e crescerebbe anche il reddito disponibile per le famiglie. Il che contribuirebbe alla discesa dei tassi perché sarebbe sostenuta la domanda di risparmio e di titoli di Stato. Le tasse sul risparmio non verrebbero modificate. “Io mi occupo di fisco soprattutto per legittima difesa” dice Martino: “occorre semplificare il 740, ridurre il numero dei tributi, ridurre la progressività eliminando le aliquote più elevate e cessare di punire tanto i redditi più bassi: in Italia le aliquote partono dal 27 per cento e arrivano oltre il 50; in America le massime sono sul 28-33 per cento”. Gradualmente, inoltre, si passerebbe a una privatizzazione di molti servizi di assistenza sociale: fatti salvi i diritti acquisiti, nel lungo termine secondo l’economista di Forza Italia le pensioni e la sanità sarebbero garantiti solo ai bisognosi, mentre per gli altri si privilegerebbero assicurazioni private e fondi pensione, ai quali i risparmiatori sarebbero indirizzati anche fiscalmente. Tutto questo, unito alle previste agevolazioni per le imprese che assumono, specialmente nel Mezzogiorno, dovrebbe servire a rivitalizzare l’economia tanto da aumentare le entrate fiscali complessive e quindi risanare i conti pubblici. “Ma attenzione: ci vorr_ tempo per disfare tutto quanto é stato fatto in passato”. Questi concetti decisamente liberali, secondo Martino, trovano oggi un grande consenso: “Se il Partito liberale se ne fosse stato fatto portatore negli anni Ottanta, la Lega non avrebbe trovato lo spazio politico di crescita che ha trovato”.
Liberismo e federalismo fiscale
In effetti, il liberismo di Martino non si discosta molto dall’esplicito federalismo fiscale di Giancarlo Pagliarini, economista della Lega Nord. Nel breve, il sentiero stretto già imboccato dai governi di Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi resta l’unico percorribile: “La situazione attuale é tanto tragica che non si può toccare troppo”. Le riforme più immediate sono quelle che servono a uniformare l’Italia al contesto europeo: al primo posto la riduzione delle imposte sulle società che oggi superano il 52,2 per cento mentre nel resto del continente sono comprese tra il 30 e il 40 per cento. Per quanto si riferisce ai risparmiatori, Pagliarini propone di bloccare l’aumento delle tasse sulle case (“un settore produttivo che non va bloccato dal fisco”), anche se l’Ici non potrà essere ulteriormente ridotta. Gli investimenti azionari saranno favoriti soprattutto dalla crescita del mercato borsistico: “Vogliamo una borsa telematica dove siano quotate almeno 5 mila aziende. Vogliamo che si quotino i produttori di calze del bresciano come gli albergatori di Siracusa”. Nel medio termine, inoltre, la strada della Lega sarà soprattutto quella di passare al federalismo fiscale: “Deve passare il principio che i soldi incassati in un territorio sono di proprietà di quel territorio. L’ente locale li trasferirà allo Stato, per coprirne le necessità. Che nel tempo caleranno, localizzando la fornitura dei servizi, dalla sanità all’istruzione”. Ai fondi pensione, che non utilizzeranno solo il Tfr ma sempre più gli stessi contributi pensionistici, il compito di sostenere e far crescere il mercato sia della borsa che delle grandi opere pubbliche.
Nessuna forza politica, dunque, pensa ad aumentare le spese dello Stato. Il Patto di Segni é più possibilista. Il Pds più programmatico. La destra più drasticamente orientata a tagliare. Ma fatte le debite distinzioni, da questo punto di vista il discorso cambia poco. E si può tranquillamente prevedere che in effetti i teorici dell’aumento della spesa pubblica non torneranno di moda per lungo tempo.
Le variazioni più importanti tra i programmi si trovano sul piano istituzionale, poiché le maggiori forze politiche sembrano caratterizzarsi più che sulla visione di breve termine, sulla concezione del ruolo e dell’organizzazione dello Stato. In particolare, si distinguono proposte federalistiche, argomentazioni più orientate al decentramento e opinioni che si mantengono su posizioni centralistiche. Queste indicazioni non corrispondono precisamente alle collocazioni di destra, sinistra e centro. Innanzitutto perché a destra si va dal federalismo settentrionalista della Lega al nazionalismo protestatario dei seguaci di Gianfranco Fini, mentre nel Patto per l’Italia convivono il centralismo di un Augusto Fantozzi e il federalismo fiscale di un Giulio Tremonti. Infine a sinistra, il programma di decentramento del Pds, come l’attenzione al localismo della Rete che é molto radicata in Sicilia, sembrano relativamente dimenticati da Rifondazione Comunista. Insomma, non é nell’analisi delle posizioni dei partiti espresse nel corso dell’ultima campagna elettorale nazionale che si trova la soluzione al problema posto, e cioé come debba il Meridione porsi nei confronti dell’idea federalista.
Per rispondere é invece prioritario condurre un’analisi generale degli interessi economici, politici e culturali del Meridione, per confrontare poi le conseguenze che su questi piani potrebbero venire dalle soluzioni centralistiche, decentralistiche e federaliste. Tenendo ovviamente presente che nessuna condizione istituzionale può risolvere tutto ma può solo contribuire alla soluzione. L’obiettivo di una ricerca sulle innovazioni istituzionali, la cui efficacia dipenderà comunque dal modo in cui le popolazioni le sapranno e vorranno interpretare e ad esse vorranno partecipare, é quello di comprendere come ricostruire un sistema legittimo nel Meridione, dunque un sistema in grado di dare una risposta sintetica al bisogno di rappresentanza, legalità ed efficienza.
Come abbiamo visto, se il Meridione contribuisce solo al 10 per cento delle esportazioni italiane, questo vuol dire che non ha una quantità sufficiente di aziende capaci di vendere i loro prodotti sui mercati concorrenziali internazionali. Infatti, la maggior parte delle imprese che operano nel Meridione si occupano di settori protetti dalla competizione e alimentati come fiori di serra dalla spesa pubblica. E’ facile dunque prevedere che queste imprese, nelle attuali condizioni, non hanno un grande futuro.
Ma c’é di peggio. Se il Meridione ha percentuali di disoccupazione doppie o triple rispetto a quelle del Nord, questo vuol dire che non ha abbastanza aziende neppure per coprire i propri bisogni. La soluzione a questo genere di problemi é una sola, almeno secondo gli economisti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il mega centro di ricerche dei Paesi più sviluppati che ha sede a Parigi: la creazione di nuove imprese. Una soluzione che si ottiene attraverso politiche non finanziate con il debito degli Stati centrali, perché é stato dimostrato che queste tendono a creare situazioni tanto inefficienti da alimentare invece che ridurre la disoccupazione. Le politiche che hanno dimostrato di funzionare in tutto il mondo sono quelle che sono nate e sono state portate avanti da organismi territoriali, più vicini alle esigenze della popolazione, più in grado di comprendere quali risorse locali possono essere efficacemente sfruttate per generare iniziativa imprenditoriale in grado di autoalimentarsi. Le soluzioni proposte sono molte. Si va dai parchi scientifici e tecnologici, agli incubatori per nuove imprese, agli organismi misti, pubblico-privati, in grado di coordinare gli sforzi per l’indirizzo dei programmi di formazione e di informazione in funzione del lancio di nuove aziende. In tutti i casi, si tratta di enti centrati sulle realtà locali.
Lo sviluppo delle aree meno avanzate non si può infatti lasciare alle libere forze del capitalismo. Il capitalismo, infatti, come spiegava lo storico francese Fernand Braudel, é il sistema nel quale prevale la legge del più forte, di chi ha enormi risorse e alleanze politiche. Non é innovazione ma monopolio, non é concorrenza ma sfruttamento di posizioni dominanti.
Ma lo sviluppo non passa, ormai é ampiamente dimostrato, neppure dalla spesa pubblica decisa centralisticamente, che in fondo non é altro che capitalismo di Stato. La maggior parte della spesa pubblica nel Meridione si é infatti indirizzata al mantenimento di dipendenti statali, non ha creato infrastrutture utili allo sviluppo locale, non ha neppure fornito servizi pubblici di livello accettabile. Anche puntando nell’immediato su un nuovo programma di opere pubbliche, non si può non considerare la necessità che i capitali vengano spesi in modo più efficiente di quanto non sia stato fatto in passato.
Il federalismo? Proviamo a guardarlo da Sud
È a questo punto che entra in campo il federalismo visto da Sud. La spesa dello Stato centrale é strutturalmente inefficiente. Non basta cambiare il governo per renderla efficace. Lo dimostra il fatto che non é stato soltanto il malgoverno romano del dopoguerra a fallire. Anche a livello internazionale, secondo l’Ocse, i piani di sviluppo che hanno funzionato sono quelli che sono stati decisi e gestiti da organismi più territorialmente avvertiti. In Italia, tutt’al più, c’é stata una parossistica inefficienza dello Stato centrale che ha sempre gestito in maniera clientelare le risorse che raccoglieva e che redistribuiva con il sistema dei trasferimenti alla periferia. “Un meccanismo che ha sempre premiato gli sprechi rispetto al buongoverno” dichiara Victor Uckmar, uno dei più noti fiscalisti italiani. L’unica soluzione é nella responsabilizzazione degli enti locali. Una responsabilizzazione molto più accentuata di quanto non sia prevedibile da qualunque forma di decentramento.
Non si tratta infatti di trasferire più soldi dal centro alla periferia. Si tratta di costruire meccanismi istituzionali che servano a controllare l’utilizzo dei capitali, che servano a valutarne costantemente l’efficace impiego. Il principio é presto enunciato: “Bisogna avvicinare l’amministrato e l’amministratore” dice Uckmar. Non in modo generico, però. Attraverso meccanismi inderogabili. Quelli del federalismo, appunto. Li precisa Pia Saraceno, dell’Irs: “Invece di raccogliere le tasse centralmente e poi trasferire i soldi alle Regioni, si vuole raccogliere e spendere localmente, salvo trasferire una quota al centro e alle aree di cui si vuole sostenere lo sviluppo”. Secondo l’Irs, per svolgere le sue funzioni, allo Stato centrale basterebbero 100 mila miliardi, mentre agli enti locali si potrebbe affidare una disponibilità di 400 mila miliardi. Senza aggravi complessivi per i contribuenti.
Sia chiaro. Quello che qui si propone non é un ritorno al passato, a prima della riforma tributaria del 1971-73, quando gli enti locali avevano ampia libertà d’azione in campo fiscale. “A quel tempo” ricorda Uckmar “s’erano verificati autentici abusi da parte del potere comunale sui singoli contribuenti”. E neppure di favorire un decentramento assurdo del tipo di quello goduto dalla Regione Sicilia, giunta anche nel marzo del 1994 agli onori delle prime pagine dei quotidiani nazionali per una decisione straordinaria: la concessione di un aumento di stipendio di 200 mila lire ai suoi 20 mila dipendenti, proprio mentre gli stessi sindacati nazionali non chiedevano per il pubblico impiego aumenti superiori alle 14 mila lire, in ottemperanza alla necessità di contenere i buchi di bilancio statale. “Opportunismo, favoritismo e clientelismo” hanno tuonato i vertici di Cgil, Cisl e Uil. Lo statuto speciale trasforma “la Regione siciliana nel migliore alleato di Bossi” ha commentato Michele Vullo, segretario della Funzione pubblica Cgil, che ha denunciato la decisione come una “scelta ignobile. C’é uno strano baratto fra alti stipendi scambiati con il silenzio della base sul malaffare di una Regione decisa a gestire risorse e appalti sottraendoli ai Comuni e agli enti periferici”. Una tale situazione é il tipico frutto di un decentramento della spesa non accompagnato dalla responsabilizzazione per quanto riguarda le entrate. In sostanza é la dimostrazione che la soluzione istituzionale non é l’autonomia regionale, ma il federalismo.
Come puntualizza il tributarista Giulio Tremonti, vicino ai pattisti di Mario Segni, che con Giuseppe Vitaletti all’argomento ha dedicato il recentissimo libro Il federalismo fiscale. Autonomia municipale e solidarietà sociale (Laterza 1994): “Oggi si tratta di realizzare un vero federalismo. Che significa autogoverno, insieme, amministrativo e fiscale. A ogni livello territoriale va assegnato un potere di entrata e di spesa con la logica del budget aziendale”. Come dire che ogni livello politico deve avere autonomia impositiva e deve sapere di non poter spendere più di quanto raccolto attraverso le imposte locali di sua competenza.
Le forze politiche, a ben vedere, hanno idee diverse su quali imposte assegnare localmente, quali mantenere centrali e sull’entità del trasferimento al governo. Antonio Martino, economista di Forza Italia, lancia una provocazione: “Va tolta la potestà impositiva allo Stato per attribuirla in esclusiva agli enti locali”. E Pagliarini della Lega afferma: “Deve essere chiaro il principio che i soldi raccolti con le tasse in un territorio appartengono ai cittadini che abitano in quel territorio”. Il Pds propone nel suo programma di “mantenere allo Stato i contributi sociali (destinati a finanziare le pensioni), mentre le imposte vanno ripartite metà e metà tra governo centrale e livelli decentrati”. Le differenze dipendono da quali funzioni pubbliche le forze politiche pensano che debbano restare allo Stato centrale e da quanto grande sia l’ammontare da destinare alla redistribuzione territoriale per sostenere lo sviluppo delle aree meno avanzate. Ma al di là delle diverse proposte, tutti evidenziano quale sia il principale vantaggio del rinnovamento istituzionale proposto: il controllo democratico delle spese. Tuona il Pds: “Basta con i conflitti centro-periferia, con la convinzione diffusa che le tasse siano destinate solo alle esigenze di Roma”. Aggiunge Tremonti: “Saranno creati meccanismi di controllo da parte dei contribuenti”. Incalza Martino: “E gli amministratori locali dovranno per forza essere responsabilizzati nelle loro decisioni di spesa”.
Stabilire le tasse e la capacità di spesa
Insomma: il primo passo di questo federalismo non più visto solo con gli occhi dei Settentrionali, é forse quello decisivo. Si tratta di riunire in un unico livello di decisione democratica la capacità di stabilire le tasse e la capacità di spendere. La spesa costituisce infatti uno dei sistemi attraverso i quali i politici cercano consenso. E indubbiamente lo stabilire le tasse é uno dei momenti nei quali i politici mettono questo consenso a rischio. Dunque, agli stessi politici oltre all’onore di poter spendere deve spettare l’onere di stabilire quanto i cittadini debbano pagare di imposte. Questo costituisce un rapporto democratico molto preciso: il cittadino paga per avere in cambio un servizio. Così é spinto a controllare che il servizio valga il denaro che é stato speso per fornirlo. Compito dell’opposizione, come avviene in tutte le democrazie, sarà quello di raccogliere il dissenso sull’operato di una amministrazione e vincere le elezioni successive per poi dimostrare di essere, eventualmente, capace di fare meglio.
Questo principio non può non favorire allo stesso modo il Sud e il Nord. Perché risponde al bisogno, avvertito ovunque, di controllare la qualità del servizio pubblico allo stesso modo in cui si controlla la qualità di ciò che si compra privatamente. E’ una questione, innazitutto, di trasparenza. Scrive Giuseppe De Rita, presidente del Cnel: “Abbiamo vissuto negli ultimi quindici-venti anni una fase di rancore e fastidio crescenti nei confronti delle amministrazioni, centrali e periferiche, che in parte sono dovuti a una qualità dei servizi relativamente bassa, alla inefficienza dei servizi pubblici centrali e periferici, ma sopratutto a una sorta di opacità che tutti i cittadini avvertono tra i loro interessi, i loro bisogni e la realtà degli interventi della pubblica amministrazione”. Ciò che compriamo privatamente dipende da noi, continua De Rita, e decine di riviste specializzate ci aiutano nella scelta, mentre chi offre i servizi e i prodotti tende sempre più chiaramente a comprendere che devono farsi in quattro per assistere i clienti negli acquisti e per battere la concorrenza. “Nel momento in cui usciamo dalla sfera del privato e del domestico, la qualità non é più affidata a noi, é affidata ad altri, noi possiamo solo darne un giudizio negativo: sugli insegnanti, sulla nettezza urbana, sulla qualità dei trasporti pubblici. Questo alla fine crea una divaricazione tra la soddisfazione di poter esercitare nel privato l’opzione di qualità, e l’impossibilità di farlo nella sfera eétra-domestica ed eétra-privata, cioé pubblica. Era inevitabile che la divaricazione crescente portasse al rancore e al disprezzo per un’amministrazione o per delle amministrazioni che non ci danno qualità adeguate o che si creasse in noi il sospetto che il servizio serve più a chi lo eroga che all’utente, serve più al postino che alla persona che aspetta la posta e più all’insegnante che alla persona che manda i figli a scuola”. Il Sud é tanto più colpito da questo fenomeno in quanto la spesa pubblica nel Mezzogiorno é più concentrata sul mantenimento del personale statale e meno sulla qualità dei servizi che al Nord. Anche per questo la gente del Sud, come dice Putnam, accomuna nel giudizio di illegittimità le amministrazioni statali e quelle regionali, mentre i settentrionali tendono almeno a salvare le autorità locali. Ma per tutti gli italiani resta il problema di costruire un sistema che consenta, e anzi imponga, una maggiore trasparenza nei rapporti tra pubblico e privato. “Non é solo l’utente” conclude De Rita “ma anche l’amministrazione ad aver bisogno di trasparenza, altrimenti il suo servizio, la sua legittimazione al servizio, la sua legittimazione ad operare, la sua capacità di essere classe dirigente di quel servizio vengono a cadere. In questa prospettiva ci sono due riferimenti fondamentali: da una parte dare spazio a chi usa il servizio (quindi le associazioni dei consumatori, degli utenti, i difensori dei diritti di vario tipo), e dall’altra, invece, dare spazio alla riflessione di chi esercita e gestisce il servizio, cioé delle amministrazioni, specialmente quelle locali, che in qualche modo si devono ritrovare per vagliare le proprie esperienze e per capire che cosa stanno facendo”.
Dare più spazio alle amministrazioni locali per ricostruire la legittimità del sistema politico: il che significa, innanzitutto, redistribuire i poteri e innovare le istituzioni. Armando Sarti, consigliere del Cnel, non esita a preconizzare l’avvento di una nuova “età comunale” per determinare una svolta nel governo degli enti locali, delle loro aziende e delle Usl. Un nuovo apparato di leggi é già oggi in opera, scrive Sarti: “I fattori che favoriscono questo rinnovamento sono: l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, cioé la possibilità di avere una Costituzione locale; gli istituti di partecipazione, i diritti di accesso e di informazione, che tendono ad affermare la partecipazione come un elemento della qualità globale dei servizi e come variabile economica positiva; i più precisi e definiti compiti e funzioni dei Comuni, delle Provincie e delle Aree metropolitane, le forme associative e di cooperazione, gli accordi di programma, le joint ventures intercomunali; le competenze più specificate dei Consigli comunali e provinciali, del Sindaco e del Presidente, che hanno liberato i Consigli, veri organi di indirizzo e di controllo, dall’appesantimento di tante incombenze; un governo (sindaco, presidente e giunte) eletto entro un termine vincolante; l’elezione sulla base di un documento programmatico; la sfiducia costruttiva attraverso la revoca e la sostituzione”. Ci vuole tempo perché le nuove leggi abbiano effetto. Ma ci vuole soprattutto una maturazione dei sistemi di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Non basta il decentramento. Il fatto é, insomma, che per mettere in piedi un servizio pubblico davvero più trasparente, ci vuole un meccanismo istituzionale che faccia sentire ai cittadini di essere i veri proprietari degli organismi che lo producono. E un sistema politico che faccia sentire agli elettori di essere determinanti per la sua direzione.
Il quadro istituzionale, infatti, deve essere organizzato in modo da consentire ai cittadini di determinare quali servizi debbano essere forniti dal pubblico e quali dai privati, di controllare la qualità dei servizi pubblici e di indirizzare quelli affidati ai privati in maniera che rispondano alle esigenze della gente, democraticamente stabilite.
Il federalismo può essere un quadro istituzionale capace di rispondere a questi requisiti. I settori di intervento pubblico e quelli da affidare ai privati possono essere stabiliti in maniera diversa a seconda delle caratteristiche delle economie e delle culture dei vari Stati federali. La qualità dei servizi pubblici può essere meglio controllata in un ambito politico più preciso e coerente. Le regole che controllano il mercato e la concorrenza possono essere adattate alle condizioni di maggiore o minore sviluppo economico.
Proviamo ad immaginare il futuro
Che cosa significa tutto questo per il Sud? Che cosa può portare questo cambiamento? Si può prevedere che la vita a Napoli, in uno Stato federalista, migliorerebbe o che peggiorerebbe? Per rispondere vale la pena di distinguere la questione in almeno tre parti: economia, politica, cultura.
Le più recenti scoperte della ricerca sullo sviluppo economico indicano chiaramente che il mondo é cambiato. Non sono le politiche economiche nazionali a determinare il successo dei piani di sviluppo, ma il modo in cui le decisioni vengono applicate e gestite nella pratica a livelli territoriali più precisi. Proprio per sostenere questa tesi, Michael Porter, professore ad Harvard, tra i massimi esperti mondiali di economia aziendale, ha scritto un articolo dal titolo La ricchezza delle regioni, un chiaro aggiornamento del classico La ricchezza delle nazioni, il libro di Adam Smith, considerato il fondatore della scienza economica. La competitività, sostiene in sostanza Porter, non é un fenomeno nazionale: le industrie hanno successo nelle regioni dove si trova una massa critica di conoscenza specializzata, dove si formano insiemi di imprese simili che si fanno concorrenza. L’Italia é spesso esemplare, da questo punto di vista, perché é la terra dei distretti industriali. I più famosi a livello mondiale sono quelli del tessile di Biella e Prato, delle ceramiche di Sassuolo, del mobile della Brianza. Più recenti ma altrettanto potenti sono i distretti dell’occhialeria del Cadore, della sedia nella provincia di Udine, dello scarpone da sci di Montebelluna. Pochi osservatori si sono accorti dei distretti meridionali. Eppure tra Melfi, Avellino e Pomigliano sarà a pieno regime, da quì a pochi mesi, il polo di produzioni autoveicolistiche sul quale la Fiat giocherà il suo futuro. Nella stessa Napoli non mancano le filiere produttive che hanno caratteristiche analoghe a quelle dei distretti industriali del Nord: la pelletteria del centro partenopeo é ad esempio un fenomeno di prima grandezza. E pochissimi sanno che alla periferia Nord di Napoli é nata attorno alla IPM, azienda che detiene la leadership europea delle telefonia pubblica, una serie di aziende che, partite come fornitrici, si sono poi sviluppate autonomamente ed hanno conquistato propri mercati e livello europeo e mondiale. A Salerno si trova il distretto del pomodoro, che ha un potenziale di leadership mondiale. E a Solofra (Avellino), quello della concia.
È probabile che la relativa sottovalutazione dei distretti napoletani e campani dipenda da molti fattori. La pelletteria del centro partenopeo, ad esempio, manca di un marchio leader che faccia le funzioni di Marazzi e Iris a Sassuolo o di Nordica a Montebelluna. Inoltre, le difficoltà infrastrutturali e l’ambiente sociale, reso poco favorevole all’emergere di imprenditori innovativi dalla presenza di una criminalità diffusa, riducono il potenziale di crescita del settore. L’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, le possibilità di utilizzo delle aree deindustrializzate, la formazione sono sempre più fattori strategici di sviluppo fortemente dipendenti da politiche integrate di sviluppo territoriale. Sta di fatto che la vecchia politica dello sviluppo, concentrata sulle cattedrali nel deserto, ha chiaramente fatto il suo tempo. “In tutto il mondo” scrive Porter “la competitività dipende sempre di più dalle caratteristiche locali”. Ed in questo quadro, le stesse competenze artigiane a Napoli come nel resto del Mezzogiorno rappresentano una miniera d’oro, fino ad oggi poco sfruttata. Le scarpe, le borse, le cinture napoletane potrebbero conquistare i mercati e generare una quantità e una qualità di posti di lavoro molto maggiori di quelle che potrebbero essere create da un qualunque stabilimento decentrato di una grande azienda nazionale. Che cosa si può fare per sviluppare queste potenzialità? Se ne può discutere a lungo e le ricette possono essere diverse: c’é chi sostiene la necessità di incrementare l’istruzione di base, c’é chi punta sui centri di consulenza aziendale finanziati da società miste pubblico-private, c’é chi si concentra sugli investimenti nelle infrastrutture. Ma il criterio generale appena enunciato é valido in ogni caso: le scelte operate localmente sono probabilmente migliori di quelle stabilite a livello nazionale. Perché le mediazioni tra gli interessi sono più dirette a livello locale e perché la conoscenza dei problemi é maggiore. D’altra parte, le storie di aziende di successo che appartengono a un territorio hanno precise ricadute positive su quel territorio; creano un ceto sociale che può candidarsi a fare da classe dirigente, non solo nell’ambito imprenditoriale ma anche nel mondo del lavoro, e in questo modo fanno maturare il sistema politico che governa quel territorio. Tutto questo é però vero solo se l’istituzione che governa le scelte é davvero sentita come propria dalla gente.
L’esperienza dei paesi più avanzati dell’Ocse, a questo proposito, segnala di solito la superiorità dei sistemi federali. Le soluzioni tedesche e americane, ad esempio, appaiono molto spesso le più adatte a guidare le economie locali nella direzione di valorizzare al massimo le risorse locali. In una direzione di maggiore decentramento decisionale sono recentemente andati anche il Belgio, la Francia, la Spagna. Le autorità competenti sulla spesa per il sostegno dello sviluppo sono sempre più spesso le stesse autorità che presiedono alla raccolta fiscale. A livello nazionale sono decise soltanto le redistribuzioni marginali delle risorse per progetti riguardanti aree particolarmente depresse: ma in ogni caso i territori beneficiari devono partecipare alla progettazione e al finanziamento delle opere destinate al riequilibrio regionale dello sviluppo. Come dire: niente finanziamenti a pioggia, corresponsabilizzazione delle autorità politiche beneficiarie degli aiuti, preferenza per le forme di sviluppo autoalimentate dalle risorse locali.
Nuove regole per il mercato
Tutto questo presuppone il buon funzionamento del sistema di mercato. La politica dello sviluppo non é più dirigistica, é partecipata. Non é più orientata puramente al sostegno dei più poveri, richiede uno sforzo costante per migliorare la competitività. Il che implica che l’azione degli operatori, pubblici e privati, deve essere guidata dalle regole del mercato. Ma qui é necessaria una ulteriore precisazione: mercato non significa selvaggia libertà di azione, tutt’altro. Mercato significa regole: norme che garantiscano la concorrenza, che impediscano lo sfruttamento di posizioni dominanti, che favoriscano la qualità dei prodotti e dei sistemi produttivi in modo da garantire la salvaguardia dell’ambiente. Mercato significa trasparenza di queste regole. Cioé decisioni collettive sul modello di sviluppo desiderato dalla popolazione. Insomma: mercato significa democrazia economica. Una popolazione deve avere il diritto di scegliere attraverso i propri rappresentanti come spendere le proprie risorse in servizi garantiti gratuitamente a tutti i cittadini, deve poter imporre degli standard di comportamento agli imprenditori privati in tutti i casi in cui essi, con la loro azione, vanno a modificare il modo di vivere della gente. Ma i modi di vivere, le esigenze profonde, le scale di priorità variano da regione a regione. Il federalismo consente una distribuzione del potere che potenzialmente può generare decisioni diverse da regione a regione, adatte alle caratteristiche locali.
Vogliamo fare qualche esempio? A Napoli sono stati denunciati nel passato casi che si potrebbero definire di subappalto di posti di lavoro pubblico che erano quasi sempre motivati dalla necessità di avere tempo libero da dedicare ad attività che venivano giudicate più produttive. Magari sfruttando competenze artigianali che non potevano essere valorizzate nel posto di lavoro “principale”. Tutto questo é ovviamente contrario alle regole attuali del mercato del lavoro pubblico. Ma potrebbe anche segnalare la necessità di sostenere un diverso sistema di regole: più flessibile di quello nazionale, più adatto a valorizzare le qualità dei suoi lavoratori, che magari non potrebbero mantenersi facendo solo gli artigiani e che potrebbero preferire di avere un reddito per una parte formato da stipendio fisso e per un’altra dipendente dalle loro qualità di piccoli imprenditori. Se le regole di questi mercati del lavoro fossero stabilite da un corpo democratico locale potrebbe darsi che le soluzioni individuate non alimenterebbero più il sistema dell’illegalità contribuendo a far rientrare molto lavoro clandestino nell’economia formale.
I confini dell’illegalità, del resto, non variano solo in rapporto a leggi morali assolute. In molti casi sono il frutto di mediazioni. E possono essere molti i casi nei quali potrebbe non dimostrarsi utile, per Napoli, mediare con il Nord la soluzione dei propri problemi. Proviamo a fare un esempio. Se é vero che il mercato della droga é uno dei principali sostegni finanziari della Camorra, é possibile che Napoli trovi soluzioni originali a questo problema che potrebbero non essere adatte anche a Trento. Una sperimentazione di una forma di liberalizzazione controllata dell’uso di alcune sostanze oggi vietate, potrebbe ad esempio ridurne la scarsità, dunque il valore, e colpire di conseguenza i profitti illegali dei mercanti di droga.
Fantasie? È possibile. Ma non é fantasia la scoperta dell’accordo tra lo Stato di Roma e la mafia siciliana, storicamente avvenuto nell’immediato dopoguerra con la supervisione degli Stati Uniti, per la spartizione del potere in funzione anticomunista. Frutto di una mediazione di interessi nazionale e internazionale, quell’accordo non ha certo giovato allo sviluppo economico e alla maturazione politica della Sicilia. Del resto, considerazioni analoghe possono avere senso anche per la ‘Ndrangheta calabrese e per la Camorra campana. La società civile del Sud, che ha ampiamente dimostrato il suo bisogno di liberazione dallo strapotere della criminalità organizzata e la sua esigenza di democratizzazione, potrebbe oggi inventare le sue soluzioni, costruire il suo futuro senza aspettare che un’analoga volontà politica si manifesti anche in settori del paese meno sofferenti per determinati problemi. Per battere la criminalità organizzata, ad esempio, é ormai dimostrato che occorre che la gente scommetta sulla legalità più volentieri che sull’illegalità: cioé che il consenso raccolto dal sistema istituzionale democraticamente controllato sia maggiore di quello ottenuto dai poteri che si fondano sulla violenza. E’ probabile che il sistema istituzionale più capace di raccogliere tale consenso sia quello che meglio ritaglia le soluzioni sulle esigenze locali, quello che determina maggiore sviluppo, quello che la gente più sente come proprio.
Già: il problema della partecipazione é anche un fatto culturale. Anzi, forse é soprattutto questo. La gente misura la qualità della propria azione nel suo contesto, si adatta meglio al proprio ruolo sociale, in funzione di quella che considera essere la propria identità. E’ probabile che l’identità e la cultura meridionale si sia progressivamente indebolita dopo la conquista piemontese, dopo la ventata patriottica del fascismo, dopo l’emigrazione e l’accelerata industrializzazione del Paese. E’ probabile che in questo modo la gente del Sud si sia adattata a una condizione di sudditanza e non abbia espresso una volontà di cittadinanza. Abbia subito le decisioni prese da altri. Abbia tutt’al più tentato di ottenere favori inviando mediatori a Roma che sono diventati più padrini che rappresentanti democratici. Del resto, al momento dell’unificazione italiana, il Sud era appena uscito da un sistema feudale e stava tentando di sviluppare alcune proprie forme di mercato, abortite non a caso proprio con l’arrivo dei piemontesi.
Ricostruire un’identità meridionale
Ma a questo punto non c’é più tempo da perdere: é necessario ricostuire un’identità meridionale. Una cultura antica e sofisticata come quella che si trova tradizionalmente a Napoli e a Palermo, a Lecce a L’Aquila e a Sassari, va valorizzata, non più compressa. L’autodeterminazione, il senso di poter decidere il proprio destino, é una miniera di risorse, di energie. E’ ora che i sudditi meridionali diventino cittadini di uno Stato democratico che sia il loro.
Tutto questo non ha niente a che vedere con la seccessione. Nessun federalista vero direbbe che il Meridione si debba arrangiare da solo. E del resto, le aree che hanno bisogno di aiuto non sono tutte al Sud, mentre le aree che possono dare aiuto non sono solo al Nord. Scrive Gianfranco Morra in Breve storia del pensiero federalista (Mondadori 1993): “Il rifiuto dello stato assistenziale non é né il rifiuto dello stato, né il rifiuto dell’assistenza. E’ il rifiuto di una partitocrazia ignorante e proterva, che ha occupato lo stato facendo finta di assistere i cittadini, in realtà assistendo quasi soltanto se stessa, spogliando i cittadini dei loro redditi senza con ciò offrire assistenza adeguata. Il rifiuto dello stato assistenziale partitocratico potrà, anzi, fare nascere, nella Seconda Repubblica, il vero stato sociale: quello che limita il proprio potere, che organizza senza sostituire e senza espropriare coordina, consentendo così alle autonomie federali una gestione umana ed efficace del servizio sociale”. E aggiunge Morra: “Qualcuno, anche in buona fede, teme che il federalismo rompa l’unità del nostro paese e conduca alla secessione. E’ vero proprio il contrario. In senso socioculturale la secessione non é un compito da realizzare. Essa solo giuridicamente non c’é, ma nella realtà esiste da sempre. Tre Italie solo apparentemente unite, in realtà profondamente diverse per costumi, attività economiche, coscienza etico-politica, stili di vita. Il trionfo della soluzione unitaria nel risorgimento, paradossalmente incarnata dal rivoluzionario Mazzini e dallo statalista Cavour, riuscì a soffocare la prevalente proposta, laica e cattolica, della federazione, ma non riuscì a fare una reale unificazione. Massimo d’Azeglio osservò che l’Italia era stata fatta, ma non gli italiani; fu una pietosa menzogna. In realtà, neppure l’Italia fu fatta: fu occupata, non unita, statizzata, non solidarizzata; burocratizzata, non liberalizzata. La secessione del Sud data dalla proclamazione del Regno. Negli anni successivi, lungi dall’essersi attenuata, s’é accentuata. Soprattutto negli ultimi decenni, assistenzialismo e partitocrazia hanno distrutto le forze autonome dello sviluppo del Mezzogiorno, per farne una colonia da assistere e un magazzino di voti da comprare. In tal modo i problemi, anzi i drammi del Sud non si sono affievoliti, ma aggravati. Mentre la via del federalismo (che lo Stato unitario del Belgio ha sentito la necessità di percorrere), proprio perché é la via dell’autonomia e della collaborazione, potrebbe porre il Mezzogiorno sulla giusta via per risolvere i suoi problemi, in quanto le poche unità costituenti la federazione sarebbero autonome di scegliere quel modello di sviluppo e quelle relazioni economiche, che risultassero più consone alla propria realtà socioculturale. Né uniformità, né secessione ma federazione e unificazione: non é un caso che gli stati più saldi del mondo siano proprio quelli federali”.
Né é probabilmente un caso che l’attività di perequazione tra le aree più e meno sviluppate trovi un maggiore successo proprio negli Stati federali. E’ un compito preciso del governo centrale, ad esempio, in Svizzera. Si legge nella Costituzione elvetica, all’articolo 42-ter, che “La Confederazione promuove la perequazione finanziaria fra i Cantoni. Nell’assegnazione di sussidi federali, deve essere tenuto conto, in particolare, della capacità finanziaria dei Cantoni e delle condizioni delle regioni di montagna”. In ogni caso, comunque, i bilanci degli Stati o dei Cantoni e quello del governo centrale, sono autonomi e reciprocamente indipendenti. La finalità é proprio quella di responsabilizzare i governi locali e centrali nell’uso delle risorse che chiedono alla popolazione. Le istituzioni federali sono per propria natura votate a una gestione finanziaria sana.
Non si può certo dire lo stesso del sistema centralistico italiano. L’enormità del debito pubblico lo dimostra. Ed é ormai dimostrato che proprio l’insano sistema fiscale italiano é stato coscientemente utilizzato dal vecchio regime di Tangentopoli per sostenere sé stesso e le sue cattive abitudini. Scrive Tremonti: “Il sistema fiscale é stato parte fondamentale di questo regime. Per un triplo ordine di ragioni, relative alla concentrazione, alla posizione, alla applicazione del potere finanziario e fiscale. E in particolare: a. il potere finanziario é stato per cominciare totalmente concentrato nello Stato, attraverso l’azzeramento dell’autonomia finanziaria degli enti locali, trasformati in puri centri di spesa (qualcosa come 30 mila sportelli di spesa sparsi sul territorio); b. il potere finanziario dello Stato é stato poi sviluppato nel modo più radicale possibile; si é infatti ripudiato il modello fiscale “liberale”, che si basa sulla detassazione del reddito risparmiato e investito dai privati, per loro libera scelta e sul libero mercato, in usi e impieghi socialmente meritevoli: fondi di previdenza, assistenza, eccetera; all’opposto si é adottato il modello più radicalmente “fiscale”, basato sulla tassazione di tutto il reddito prodotto (salva una sterminata franchigia a favore dell’evasione) e sulla sua redistribuzione in forma di spesa pubblica; é questo, evidentemente, il modello di organizzazione della finanza pubblica che assicura allo Stato la possibilità di esercitare al massimo grado la funzione di intermediazione e di arbitraggio nella circolazione e nella distribuzione della ricchezza; é lo Stato a prelevare, é ancora lo Stato (non i privati, non le famiglie, non il mercato) a decidere ciò che é socialmente meritevole e a produrlo (con l’Inps, con le Ussl, eccetera); c. il potere fiscale é stato legalmente modulato secondo il modello della franchigia per l’evasione e del favore per il debito: la franchigia all’evasione é stata garantita dalla legislazione fiscale, basata su regimi contabili che grottescamente costituivano a favore dell’evasore uno scudo insuperabile contro il fisco stesso; il favore per il debito, notevole in generale e soprattutto in caso di debito pubblico, é stato poi formalizzato prima dall’esenzione fiscale totale accordata ai titoli della rendita pubblica e poi da una tassazione diretta puramente simbolica, accordata alle persone fisiche portatrici anonime dei titoli stessi”. Per Tremonti non ci sarebbe stato il malgoverno degli ultimi decenni “se non ci fosse stato un fisco basato sul modello dell’evasione e del debito: evasione elettrice al Nord, benefici a pioggia nel Sud, il paese unificato dalla rendita pubblica”. E conclude: “La nuova costituzione fiscale dovrà definire cosa deve fare lo Stato e cosa può fare il mercato; cosa deve fare il governo centrale (lo Stato) e cosa devono fare i governi locali (le Regioni, le Province, i Comuni). Ancora, quanto sacrificio va richiesto alla gente, in termini di solidarietà nazionale, e quanto può essere invece richiesto dalla gente, in termini di beneficio particolare”.
Nuovi sentieri di sviluppo
Insomma: gli argomenti fin qui proposti, seppure in alcuni casi soltanto accennati, non saranno forse decisivi, ma certamente inducono a ritenere ammissibile, se non probabilmente necessario, un serio esame delle potenzialità offerte al futuro sviluppo del Meridione da un ripensamento istituzionale in senso federalista della Costituzione italiana. Che cosa si é detto, in sintesi? Che lo Stato centralistico non é stato in grado di attuare una politica economica realmente efficace per avviare il Meridione in un sentiero di sviluppo capace di autoalimentarsi. Che non ha saputo neppure offrire al Sud un sistema di servizi pubblici paragonabile per qualità a quello realizzato al Nord. Che alla radice di molte inefficienze c’é stato un insieme di decisioni che, se avevevano come effetto collaterale un trasferimento di risorse finanziarie in favore delle regioni del Sud, erano pensate e gestite in maniera coscientemente orientata a fare principalmente gli interessi del centro politico della nazione. È questo lo scandalo più incredibile e ingiusto che é ormai venuto alla luce. Il meccanismo era tanto semplice e connaturato al sistema centralistico da essere alla fine divenuto persino ovvio: ottenere stanziamenti per Napoli, ad esempio, significava andare a Roma a chiederli, accettando di dipendere dallo Stato centrale anche per l’assegnazione di fondi pubblici che in parte lo stesso Meridione aveva prodotto. Mediando a Roma, i rappresentanti del potere politico napoletano diventano di fatto gli esecutori di una strategia che prevedeva la cessione di autonomia decisionale e creativa in cambio di soldi. Purtroppo, non é possibile affermare che se i fondi spesi in questo modo nel Meridione fossero stati gestiti completamente dai rappresentanti politici locali i loro effetti sarebbero stati miglior. Quasi sempre, infatti, i politici nazionali sono stati gli stessi che, come abbiamo visto, di nome o di fatto, da soli o in “associazione” hanno gestito tali fondi a livello locale. Di sicuro si può però affermare che nel modo in cui sono stati utilizzati, si sono rivelati ben poco produttivi.
Il problema attuale non é tanto quello di andare a vedere che cosa succede adottando un altro sistema, quanto quello di costruire sulla base dell’esperienza, dei meccanismi istituzionali in grado di ovviare alle inefficienze del passato regime.
Il federalismo non é un demonio da esorcizzare, partorito dalla Lega Nord. Lo dimostra il fatto che lo stesso Pds, in particolare quello dell’Emilia Romagna, ci sta pensando in maniera quanto mai approfondita. Un esame delle conclusioni di tale ricerca può servire in questo libro proprio per liberare la mente dai pregiudizi, prima di passare a una riassuntiva serie di proposte per un federalismo visto da Sud.
Luigi Mariucci, consigliere della Regione Emilia Romagna, ha fatto un primo passo, decisivo, nel novembre del 1992, proponendo una riforma dello Stato in senso regionalista con argomentazioni francamente federaliste. “Un vero ordinamento regionalista, come insegna l’esperienza comparata, non può incidere solo nella distribuzione dei poteri e nel modo di acquisire risorse. Deve investire la forma dello Stato, le funzioni e le strutture del Parlamento. In un ordinamento regionalista occorre che le Regioni, le comunità regionali siano rappresentate nel centro costituzionale della Repubblica”. Altro che mero decentramento! Mariucci vuole portare fuori le Regioni dal semplice localismo per dare loro una rilevanza istituzionale di livello nazionale. Del resto, l’”ispirazione federalista” era prevista in un progetto di riforma istituzionale proposto dal Pds bocciato di stretta misura alla Bicamerale. Ed é ancora Mariucci che afferma senza mezzi termini che “federalismo” non va considerata una “cattiva parola, per la paura dell’uso ambiguo che di quella parola fanno le Leghe”, anzi. “Federalismo é una parola che appartiene alla tradizione democratica e progressista, da Kant a Proudhon, da Hamilton a Carlo Cattaneo, fino a Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. È un filone di pensiero che attraversa le migliori culture politiche dell’Ottocento e del Novecento, il pensiero liberale, democratico, cattolico-democratico e anche socialista. Federalismo é un modo per unire e non per dividere: é una concezione pluralista del potere e della società, una concezione quindi anti-giacobina, anti-autoritaria, pacifista. Federalismo significa dire che l’organizzazione politica della comunità va costruita non concentrando i poteri al centro, ma articolandoli, dal basso, trattenendo nelle comunità locali e regionali i poteri necessari all’autogoverno e trasferendo ai livelli superiori i poteri necessari ad assicurare l’unità e la sicurezza della comunità. Federalismo non significa, dunque, chiusura egoistica e localistica. Significa al contrario cosmopolitismo: non ci sarà unità europea senza federalismo, così come non ci sarà governo democratico dell’ordine mondiale senza elementi di federalismo. Perciò io penso che, nella situazione italiana di oggi, dove occorre ricostruire su basi nuove l’unità e la solidarietà nazionali, in prospettiva europea, l’uso di questo termine (“ispirazione federalista”) sia corretto”.
Mariucci quindi propone la netta distinzione delle competenze di Stato e Regioni, prevedendo esplicitamente i compiti (limitati) del governo centrale e attribuendo alle autorità locali competenza su tutte le altre materie. E’ il rovesciamento del pricipio costituzionale attuale, che invece prevede esplicitamente ciò che le Regioni devono fare, limitandone molto l’autonomia, e lascia tutto il resto allo Stato. Inoltre, Mariucci propone che il Senato si trasformi nell’assemblea parlamentare che rappresenta le Regioni cessando di essere solo un inefficiente doppione della Camera dei Deputati.
Anche nel Pds si torna così a citare Carlo Cattaneo: “Occorre cedere ad istituzioni politiche superiori quella sola parte di potere che torna utile cedere per la migliore funzionalità della vita sociale e trattenere invece tutti i poteri di cui non si possa dire altrettanto, amministrandoli nell’ambito delle circostrizioni che sono nate dalla storia e hanno in essa la loro patente di legittimità”. A Bruéelles, questo principio é diventato la base fondamentale dell’azione dell’Unione europea e si chiama “principio di sussidiarietà”: nessun livello superiore deve occuparsi di materie che possono essere efficacemente trattate da un livello inferiore. I poteri fondamentali che servono alla vita collettiva vanno affidati a entità riconosciute come proprie dalla gente: le Regioni o forse le macroregioni che meglio rispecchiano la storia profonda del Paese, sono le aggregazioni che possono aspirare a ottenere la massima legittimità. Saranno poi le macroregioni, volendosi mantenere unite tra loro per dare vita a uno Stato federale più forte della somma delle sue componenti, a cedere una parte dei loro poteri al centro. Definendoli strettamente, però, in modo da non perdere autonomia e creatività decisionale.
Il mutamento rispetto al vecchio regionalismo non potrebbe essere più ampio. Il significato politico e amministrativo delle Regioni era già limitato dalla Costituzione, che destinava al centro tutta l’autonomia e la creatività decisionale, lasciando alle Regioni solo alcuni compiti definiti e standardizzati. Era poi stato definitamente ucciso dalla riforma tributaria dei primi anni Settanta, non a caso decisa proprio nel momento in cui le limitate autonomie regionali comunque previste dalla Costituzione venivano finalmente realizzate, con una ventina d’anni di ritardo. Pur di non perdere neppure un briciolo del suo potere, lo Stato centrale ha eliminato ogni libertà impositiva degli enti locali, li ha resi dipendenti dai trasferimenti decisi da Roma, li ha trasformati in sottoprodotti del sistema centrale. Lo conferma lo stesso Mariucci: “Le attuali Regioni sono la testimonianza del fallimento annunciato del vecchio regionalismo. Le Regioni finora infatti hanno riflesso tutti i mali del sistema politico e istituzionale: esse sono prive di identità, e sono quindi intese come pure agenzie di spesa decentrata. Perché riflettono, nella loro organizzazione interna, il modello ministeriale: gli assessorati sono attrettanti feudi, costruiti, appunto, sullo schema ministeriale”. Fa addirittura impressione ascoltare parole e concetti di questa precisione e durezza da un amministratore che ha davanti agli occhi l’esperienza dell’Emilia Romagna. E’ la ennesima dimostrazione del fatto che quando si parla della Campania, dire che non ci sono parole non é soltanto un eufemismo, ma la consapevolezza allo stesso tempo dei gravissimi ritardi e delle grandissime responsabilità che gravitano di fatto sui campani nella fase che si potrebbe aprire da quì a poco.
Le conseguenze di politica economica che potenzialmente sono contenute in una riforma federale dello Stato, sono stati affrontati da tutti i principali partiti, dalla Lega a Forza Italia e al Pds. Un liberismo piuttosto spinto distingue le proposte della destra. Come é giusto che sia un maggiore accento al solidarismo si trova invece nelle idee propugnate dalla sinistra. Per tutte queste forze politiche, però, l’idea federalista stimola innovazioni istituzionali e organizzative piuttosto significative. Nessuna sostiene che il passaggio al federalismo debba annullare ogni forma di trasferimento di risorse dalle regioni ricche a quelle meno sviluppate. Tutte vogliono poteri fiscali ben distinti tra livelli locali e centrali dello Stato, tutte vogliono il mantenimento della destinazione di una certa quota del gettito in favore dei meno abbienti. Variano, e spesso di molto, le quantità, ma la qualità del ragionamento sembra trovare un vasto consenso.
Sembra dunque che una serie di tabù stiano crollando. Del resto, il centralismo era il sistema preferito dal sodalizio Craéi-Andreotti-Forlani, dai loro partner finanziari, dai feudatari locali come Gava e Cirino Pomicino. Al posto del vecchio regime c’é ora una situazione nella quale non sono ancora sufficientemente definiti quali sono gli interessi prevalenti. E’ una situazione non del tutto chiara ma che comunque presenta potenzialità nuove per tutti coloro che, nel vecchio sistema, si erano visti colpiti e mortificati nei loro interessi.
In che cosa può consistere dunque un federalismo visto da Sud? In un insieme molto preciso di autonomia istituzionale, democrazia fiscale, economia di mercato e identità culturale. Non vale certo la pena di discutere quale aggregazione macroregionale vada meglio per il Sud. Che si vogliano tener distinte le isole dal Meridione continentale, che si voglia dividere l’Est adriatico dall’Ovest tirrenico e ionico, che si preferisca mantenere l’ottica consolidata delle attuali regioni o che si immagini invece di ricostituire una sorta di Repubblica delle Due Sicilie, poco importa in questa sede. L’essenziale é definire il sistema di regole nuovo che si può oggi costuire nel territorio che gravita attorno al capoluogo campano grazie alla seconda Rivoluzione napoletana.
La ricetta del federalismo
E allora si possono passare in rassegna i capitoli di questa proposta di federalismo visto da Sud. Autonomia istituzionale, innanzitutto. La regione o macroregione di Napoli si deve poter dotare di un sistema decisionale in grado di prendere decisioni ritagliate sulle esigenze della sua gente, senza mediazioni superflue con il potere di Roma, senza vivere del cordone ombelicale che fino ad ora l’ha legata e soffocata. Che cosa significa? Che Napoli pensi sia il proprio destino che la propria quotidianità come qualcosa che essa stessa può determinare, senza più aspettare il favore del padrino di turno. Un padrino che, nell’”aiutarla”, le toglie inventiva e forza propulsiva.
In secondo luogo, democrazia fiscale. Utilizzando con senso di responsabilità le risorse raccolte tra la sua gente, controllandone la destinazione più da vicino, impedendo che si disperdano nei rivoli determinati dalle vecchie, superflue mediazioni.
In terzo luogo, economia di mercato. Per regolare gli scambi di lavoro e di merci in modo adatto alle caratteristiche dello sviluppo locale, per controllare il rispetto delle leggi valorizzando l’imprenditorialità della gente. Perché emergano, all’interno delle regole, i più bravi e non i più favoriti o i più potenti. Inventandosi anche forme contrattuali che favoriscano l’accesso dei giovani al lavoro, che rispettino il bisogno di flessibilità che tanti napoletani manifestano in mille modi quasi sempre informali. Scoprendo nuove forme di lavoro “per progetti”, non necessariamente a tempo pieno, che possano aiutare a risolvere i problemi del traffico, degli anziani, dell’ambiente, della salvaguardia dei beni culturali. Lavori che oggi non si creano anche per la difficoltà di mediare tra gli interessi delle tante realtà economiche diverse esistenti in Italia, ma che potrebbero facilmente essere attuati in un contesto di autonomia istituzionale e fiscale.
Infine, valorizzazione dell’indentità culturale napoletana e meridionale. Perché, come abbiamo detto, la legittimità di un sistema dipende anche, e soprattutto, dal fatto che la gente deve sentire quel sistema come proprio, deve essere orgogliosa del ruolo che quel sistema svolge nel contesto nazionale e internazionale. Se Napoli é una città mediterranea, se la sua storia e il suo destino si giocano nel contesto economico e culturale del Mediterraneo, occorre che i napoletani sentano di poter valorizzare in pieno questa loro caratteristica. Ogni vero sviluppo si fonda e si consolida sulla capacità di trasformare le caratteristiche locali in risorse.
L’Italia si trova di fronte alla più grande ristrutturazione della sua storia recente. Il Paese ospita una doppia struttura economica e politica: da una parte, nei distretti industriali del Veneto, dell’Emilia Romagna e anche di Napoli, assomiglia a una Taiwan, iperattiva, molto produttiva, in grado di esportare in tutto il mondo, orientata a un liberismo talvolta tanto sfrenato da sfociare nell’illegalità; dall’altra parte, assomiglia a una Polonia post-comunista, dominata da un’inefficiente e onnivora macchina statale che occorre riorganizzare, privatizzare, e anche (nelle sue componenti più feudali, burocratiche e mafiose) semplicemente cancellare. Ma il Paese é maturato mentre il vecchio sistema é marcito. Ora occorre che la sua imprenditorialità venga indirizzata in un sistema di regole che impediscano gli eccessi del capitalismo selvaggio e anzi valorizzino le vere competenze, quelle che si possono efficacemente confrontare con il mercato internazionale. Occorre che i problemi ambientali e culturali che il vecchio regime si é lasciato alle spalle vengano affrontati dando proprio a coloro che li sopportano quotidianamente la possibilità e la responsabilità di decidere le soluzioni. Il sentiero della ristrutturazione é probabilmente diverso nel Nord-Est, in Piemonte, in Lombardia, nel Centro e al Sud. Il Piemonte può guardare a Detroit o a Lione. Il Nord-Est può scegliere tra un maggiore liberismo e l’applicazione di un modello alla tedesca. Il Sud può tenere presente l’esperienza delle grandi privatizzazioni dei Paesi che stanno affrontando la transizione dal socialismo reale al mercato. La Slovenia, per esempio, sta dimostrando che é possibile uscire gradualmente dallo statalismo più spinto, esportando molto, sostenendo il valore della moneta, attirando capitali e joint ventures, valorizzando le competenze manageriali degli eé-funzionari delle imprese pubbliche e trasformandole in imprenditorialità. Chi creda che tutto il destino del Sud dipenda dagli aiuti statali commette un errore imperdonabile: con un sistema più legittimato, il Meridione d’Italia potrebbe diventare una mecca per gli investimenti stranieri che cercano un buon mercato locale, elevate competenze e disponibilità di manodopera. Ma potrebbe anche, e forse soprattutto, diventare la terra promessa della piccola imprenditorialità che già oggi la popola, ma di nascosto, come temendo di essere scoperta.
La ristrutturazione del Paese non può avvenire con un unica politica uguale per tutte le aree. Una privatizzazione drastica sarebbe un dramma socialmente troppo duro per il Sud. Ma mantenere gli attuali livelli di intervento pubblico soffocherebbe le dinamiche economiche in atto, in special modo in zone come il Nord-Est. Il processo, inevitabile, di riorganizzazione dell’Italia va gestito con i tempi e i modi adatti alle varie situazioni locali. Il federalismo, visto da Sud come da Nord, é dunque qualcosa di più di una possibilità teorica: é una buona idea pratica, una strada concreta per provare a vivere meglio.